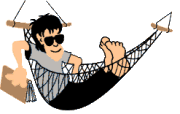Stavamo tornando da Porta Vittoria con il passante. Pomeriggio, pochi viaggiatori. Matteo aveva appoggiato la testa al finestrino, guardava il nero delle gallerie. Un po’ intontito, come sempre. Lo sguardo intelligente spento dalla droga. Il Tribunale gli aveva consentito l’uso dell’hashish per aiutarlo a smettere con la cocaina.

La madre andava a comprarglielo, come faceva anche prima che lo prendessero, ma adesso con lo scrupolo di un’infermiera.
Sedici anni, aveva iniziato a consumare cocaina a undici, alle medie. Poi, rapine. Ai benzinai, nei negozi. Il cervello ormai bruciato. Lui che comunque sapeva di essere stato un tipo in gamba anche con la testa, un tempo, adesso non ce l’avrebbe fatta con la matematica delle elementari. Una volta che l’orientatrice lo aveva messo davanti a una scheda con quattro passaggi di logica, era uscito dalla saletta e si era messo a piangere nel corridoio dei servizi sociali.
Guardava il nero fuori dalla carrozza, distante. Io lo lasciavo galleggiare nel silenzio, lo osservavo. Il silenzio spesso fa percorrere strade precluse alle parole del buon senso. Le retoriche dell’educazione si inceppano subito con uno come Matteo, e poi a me non sono mai piaciute.
{xtypo_quote_left}Un ragazzo come tanti, segnato appena da una leggera stempiatura e dagli occhi lucidi.{/xtypo_quote_left}
A un certo punto, voltandosi appena, ha detto: «Mio fratello passa le giornate sulla sua branda. In casa, non esce quasi mai. Non trova lavoro, niente. La scuola non l’ha finita».
Io non ho detto niente. Ho continuato a guardarlo. Un ragazzo come tanti, segnato appena da una leggera stempiatura e dagli occhi lucidi. La madre gli aveva concesso tutto, da sempre, aiutandolo a rovinarsi. Il padre, inesistente.
«Mio fratello non ha fatto male a nessuno» ha aggiunto. «E nessuno fa niente per lui. Io ho fatto del male a un sacco di gente, e vi date tutti da fare per me. Non lo capisco». E questo voleva dire “non è giusto”, ma la parola “giustizia” non l’ha usata, tanto che dovevano avergliela fatta pesare, dal processo in giù.

L’avevo portato in un negozio di strumenti musicali. Per l’ambiente. Matteo stava trovando una via d’uscita nella musica. Aveva iniziato a suonare la batteria, prendeva lezioni, passava le giornate, con il provvedimento di permanenza in casa, chiuso nella sua stanza a picchiare su una batteria da studio, dieci ore di fila, tutti i giorni, indifferente alle bestemmie dei vicini. Avevamo setacciato negozi e case discografiche per trovargli un posto, non un lavoro vero, perché non ce l’avrebbe fatta, ma un’idea di lavoro, una suggestione, legata alla sua passione. Quattro operazioni elementari, rispondere al telefono, sistemare gli strumenti, suonare un po’, magari spazzare per terra, di più il suo cervello non avrebbe retto. Forse per tutta la vita.
{xtypo_quote_right}lasciava margini di fiducia, c’era ancora una possibilità che non ci fosse ricascato in pieno{/xtypo_quote_right}
Un posto sbagliato, probabilmente, alla fine di una via squallida di fianco allo scalo ferroviario, tra macellerie arabe e officine. Seminterrato, malmesso. Ma per qualche tempo poteva anche andare bene, prima che trovassimo qualcosa di meglio. Ogni due ore Matteo usciva in strada a farsi uno spinello, si autoassolveva dal fatto di non provarci a resistere, facendosi bastare quello della mattina e quello della sera prima del sonno.
Non aggiunse altro, quella volta.
Quello che il nostro gruppo stava facendo per lui doveva sembrargli incomprensibile, quanto l’intero meccanismo della società e della vita. Io continuavo a non dire niente. Lo osservavo. Si era anche rasato i capelli a zero, così, diceva, solo perché li stava perdendo e non per la visita periodica al Serd, di lì a una settimana. Di questo non voleva ancora parlare con nessuno, lasciava margini di fiducia, c’era ancora una possibilità che non ci fosse ricascato in pieno. Sentivo che non era così. Sentivo anche che se non ne parlava non era tanto per non perdere la stima di quelli che lo stavano seguendo, quanto per una qualche lotta che stava facendo con se stesso, per tenere lontana la realtà, e non essere il primo a dover cedere alla sfiducia. La cocaina aveva creato una voragine di desiderio, ne parlava sempre, contava i mesi che erano passati dall’ultima volta come uno scalatore scandisce le vette della sua carriera. Sette, otto. All’ottavo era arrivato quel taglio di capelli che avrebbe compromesso tutto. Il suo sedicesimo compleanno. Un’unica volta, mi ha poi confessato, con gli occhi che gli luccicavano di piacere, una sola volta per festeggiare, l’esplosione, il fuoco, e lo smarrimento della nebbia al campo base, di nuovo, con la montagna del tempo al futuro che sembrava inarrivabile.