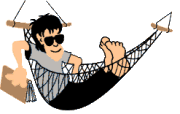Scusatemi per prima. Avrete pensato che io mi sia preso gioco di voi, in qualche misura. Un po' è vero, un po' no. In realtà mi sono preso la briga di mancare intenzionalmente di rispetto a quel processo di enfatizzazione del rischio educativo che è da tempo in atto e che temo possa cristallizzare i nostri modelli d'intervento e uniformare, con le procedure, anche le proposte educative, anestetizzando le peculiarità. Per lo più per, tra l'altro talvolta comprensibili, motivi di bilancio ed esigenze di standardizzazione. C’è un clima di gravità diffusa che zavorra l’iniziativa, laddove invece servirebbe promuoverla, anche a rischio di sbagliare dandosi l’opportunità di fare tesoro degli errori.

Vedete, la comunità che è per natura una creatura complessa, dovrebbe, a parer mio, tendere altrettanto naturalmente a quella forma di compensazione che si chiama semplicità. E non intendo semplificazione, che è la sorella minore della standardizzazione, dato che ciò che è omologato, catalogato e riproducibile viene concepito come più semplice, ma chi lo dice che lo sia?
Invece no. E così, un ambito che era solo complesso ora è pure complessato. In comunità, come negli altri luoghi dove si fa intervento educativo, vige un timore della carta che canta e dell'errore che lo rende, l'errore, inconcepibile (perciò ingiustificabile). Sbagliare non è più sintomo di umanità, ma segnale d'inadeguatezza. Peggio: lo è non lo sbagliare, ma anche il semplice rischio di sbagliare.
La normativa, che dovrebbe tranquillizzarci e tutelarci, noi e i ragazzi, staccandosi da un dimensione di quotidianità, può diventare spauracchio che induce a trattenersi. E allora io reagisco denunciando pubblicamente il mio desiderio di semplicità e d’inaugurazione di quello che a me piace vedere come un umanesimo comunitario. Le comunità, dopo un'età classica ormai remota, languono a mio avviso (mi si perdoni l’iperbole) in un sorta di medioevo tecnocratico e tecnicistico. In comunità è tempo di entrare nel Rinascimento, rimettendo l’Uomo al centro, ancor prima del gruppo e ancor prima del luogo.
Perché quando mi hanno sentito parlare con una mia collega della necessità di mettere le strisce abrasive antiscivolo sugli scalini, una delle ragazzine mi ha domandato se ci stessimo per caso trasformando in una fermata della metropolitana. E quando abbiamo dimesso la sua compagna di stanza un'altra si è presa anche il suo spazio, con una manovra di annessione che manco Hitler con l'Austria e la Cecoslovacchia, e quando le abbiamo fatto notare che no, non poteva, perché c'era in previsione una imminente nuova accoglienza ci ha guardato chiedendoci perché? Perché doveva rinunciare di nuovo a metri, aria, pace e riservatezza? Fatelo voi, diceva, provate voi a dividere la camera, e non solo, con l'ennesima sconosciuta. Dovremmo ripensare i modelli. Ascoltarci mentre parliamo per vedere se riconosciamo la voce, e se riconosciamo quel che dice.
{xtypo_quote}
Per molti dei ragazzi e dei bambini che ho conosciuto io, la comunità era ed è prima di tutto, ma molto prima di tutto, un luogo di vita, non di lavoro. Erano convinti sul serio che noi educatori fossimo lì a prenderci cura di loro perché gli volevamo bene, non per mestiere. Sì, un po' anche per quello, ma molto, molto dopo.
{/xtypo_quote}
E infatti sarà capitato a tanti di voi di sentirsi rivolgere la fatidica domanda “ma tu, davvero, che lavoro fai?” del tipo occhei, ma quando non sei qui a curarti di me, che cavolo è che fai? Com'è che ti guadagni il pane?
Ecco io ne ho una che è anche meglio. Ascoltate un po' cosa mi sono dovuto sentir chiedere alla rispettabile età di quarantacinque anni. Perché loro sono convinti di essere il centro della comunità.
- Juri - mi fa lui che ha cinque anni e beve latte e cacao.
- Ohi - gli faccio io, dalla mia tazzina di caffè.
- Ma tu - dice lui, e mi fissa - tu che lavoro vorresti fare, quando sarai grande?
Capito? Ecco, stai a vedere che fin qui abbiamo solo scherzato. Però la domanda non era affatto stupida, anzi. Era un po' come se dietro ce ne fosse un'altra, qualcosa tipo Juri, ma quando io me ne sarò andato, che cosa ne sarà di te? Cosa farai? Dov'è che andrai? Quindi un po' lo sanno, che è il nostro lavoro, anche se preferirebbero di no e infatti quando loro vanno, la comunità, la chiudono.

Sì, perché i bambini che escono dalla comunità, se la portano via, perché è una parentesi, utile e vitale, ma una parentesi e le parentesi vanno in qualche modo chiuse. Dopo di loro, secondo loro, il diluvio. Alcuni tornano, è vero, ma sono grandi e secondo me tornano anche per verificare, per vedere se siamo sopravvissuti alla loro assenza.
Ma ricordiamoci che chiudere una parentesi serve per proseguire un discorso, non per terminarlo.
Una parentesi, dicevo. E mica solo per i ragazzi…
E infatti la mia comunità si è conclusa, dopo diciassette anni di onorato servizio, quasi diciotto. Mi dispiace che sia finita. Però da un lato sono sollevato, perché era forse l'unico modo per costringermi a mettere il naso fuori, io che sono uno che se sta bene dove sta tende a non scollarsi più. Tradotto: a istituzionalizzarsi. Non è mica un rischio che corrono solo i ragazzi, questo.
Siamo andati ad esaurimento. Man mano che i bambini uscivano, non ne abbiamo inseriti altri. Ed è lì che ho capito meglio che le comunità devono darsi un respiro nuovo, perché hanno un particolare difetto. Sono un po’ affollate, ci si sta troppo a lungo, ci si muove in tanti, bisogna troppo spesso alzare la voce per essere sentiti, per esserci. Condividere è bello, ma mica sempre. Me l'ha suggerito chi, a sette anni compiuti, quando a pranzo eravamo ormai in pochi, mi ha detto “Juri, ma non pensi anche tu che adesso si sta proprio bene?” e me l'ha confermato chi, a sedici inoltrati, con otto trascorsi lì dentro, gli ha fatto eco “Minchia, davvero!”.
Comunque, adesso che la mia comunità non ha più urgenze operative, mi risulta più facile chiedermi: ma in comunità chi è che rischia? Noi o i ragazzi? E cos'è che rischia? E se c'è tutto questo rischio, ne vale allora la pena?
Eh… Ne sono passati una cinquantina, di bambini e ragazzi, dal Melograno. So cos'ho cercato di lasciare a ciascuno di loro, assumendomi i rischi dell'iniziativa. E so che tutti si sono portati via qualcosa, senza però lasciarmi più povero di come mi avevano trovato. Solo più vissuto, diciamo così. Non mi mancano dei pezzi. Anzi, forse, ce ne sono che mi avanzano... Perché c'è poi quello che loro mi hanno lasciato, non sempre tutto buono e non sempre tutto bello. Alcuni di loro erano insopportabili.
Se ne sono andati tutti, prima che me ne andassi io. Ci siamo incontrati, spesso scontrati, volenti o nolenti e, per definizione, ci siamo messi in crisi. Resta solo da definire se ne sia valsa la pena e quindi se ne valga ancora.
E vado a chiudere.
Un cantautore molto famoso disse che è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati.
Un altro cantautore, altrettanto bravo per niente famoso, dice invece che è stato meglio che un misero arrivederci, non esserci mai incontrati.
Ok? Focalizzata la differenza?
La prima è una conclusione più facile, è più da educatore, si adatta ad un ambiente dove ci piace pensare che comunque vada sarà un successo, dove non si butta via niente, perché tutto arricchisce.
Ma la vera provocazione al buon educatore la lancia quell'altro, che ti mette addosso il dubbio e ti invita, dai, ammettilo, riconoscilo che molti incontri contengono troppa delusione e sono fastidi che avresti preferito scansare e che a volte si sono risolti in miseri arrivederci. Io ne ho in mente. L'ultimo, il più fresco, si è concluso in questo modo. L'ultimo ragazzo che è uscito dalla mia comunità è uscito così, con un misero arrivederci.
È vero. Quanta fatica, a volte, e quanta delusione. Ti domandi persino se ne sia valsa la pena. Nonostante tutto però faccio fatica a dire che sarebbe stato meglio non essersi incontrati e che i rischi corsi siano stati vani. E allora le due strofe di questi artisti mi si confondono in testa e quindi dico, a chi è andato, che è stato indubbiamente sensato correre il rischio d’incontrarci, pure quando ci siamo poi lasciati con un misero arrivederci.
Testo letto nel corso del convegno “Chi educa, rischia” per i 40 anni della Coop. Soc. Comin,
tenutosi a Milano presso al Sala Alessi di Palazzo Marino il 27.05.2015